L’IMPEGNO “FUTILE” NEL CINEMA ANNI ’80
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

“La fantasia è fertile solo quando è futile”. Questa frase di Vladimir Nabokov (definito da Cinzia De Lotto e Susanna Zinato “un artista di sensibilità già postmoderna”), scritta nel 1943, potrebbe essere utilizzata per esprimere al meglio alcune delle principali caratteristiche del cinema tra la fine degli anni settanta e il decennio successivo. Fantasia senza dubbio fertile proprio perché, in molti casi, estremamente futile. Quello che potremmo definire il senso del futile non è rintracciabile, in dosi ovviamente massicce, soltanto nel cinema avventuroso, fiabesco, brillante, giovanilistico, tutti generi che comunque hanno trionfato negli anni ottanta. Ma viene declinato, con sfumature e accenti diversi, anche in film che affrontano temi seri. Si potrebbe sintetizzare il concetto con la frase: “L’impegno nella sua versione effimera”.
Tra i temi seri risalta la guerra del Vietnam e le varie problematiche che l’hanno accompagnata. Dalla fine degli anni settanta sono numerose le produzioni che se ne occupano, alcune di grande spessore. Tuttavia, nella maggior parte si possono riscontrare tracce più o meno evidenti di futile e fantasioso. Sotto forma di scene a effetto (parallelamente alla crescita esponenziale degli effetti speciali) che esasperano la suspense, la violenza, lo struggimento eccetera. Attraverso una messinscena sfarzosa ed elegante. O una leggerezza ludica. Utilizzando musiche e atmosfere sognanti. E così via.

In Un mercoledì da leoni (Big Wednesday, 1977), diretto da John Milius, l’ambientazione è una grande spiaggia californiana dove i tre protagonisti fanno surf in attesa di partire per il Vietnam. Le gigantesche onde del Pacifico, in particolare quelle dell’ultima mareggiata (il “grande mercoledì” del titolo originale), lungi dall’avere un significato metaforico secondo il regista, sono riprese con tale efficacia spettacolare da assurgere a protagoniste assolute del film. Cosicché, come ha scritto Renato Venturelli, “la ricostruzione storica cede il passo all’assoluto dello spazio mitico”.
La guerra del Vietnam viene evocata anche in un film che nasce ovviamente come prodotto di puro intrattenimento. Piranha, diretto nel 1978 da Joe Dante è, non a caso, scritto da John Sayles, regista e sceneggiatore tra i più attivi, politicamente, del cinema americano. Il Vietnam nella vicenda non ha ruolo marginale. Infatti in un fiume della California viene inavvertitamente liberato un branco di feroci piranha mutati geneticamente dall’esercito americano per sterminare i Vietcong. Ovvio che poi il film diventi soprattutto un thriller acquatico, realizzato magnificamente sotto ogni punto di vista.
Dello stesso anno è Il cacciatore (The Deer Hunter), film che affronta la guerra del Vietnam con grande dispiego di scene madri, musica evocativa (e straniante, con il pezzo “Can’t Take My Eyes off You” che contrasta con il tono generale del film) e un surplus di atmosfere malinconiche e di pathos evocativo. Di tutto ciò il regista Michael Cimino si dimostrerà un maestro e Il cacciatore il capostipite di certo cinema postmoderno che contamina con elementi disarmonici il materiale narrativo e tematico, evitando in questo modo ogni potenziale scivolata nell’enfasi retorica. Esemplare in tal senso la scena più celebre del film, quella della roulette russa. L’asincronia ludica sembra disinnescarne la drammaticità e con essa la sovrastruttura interpretativa. Sembra, appunto, e sta qui forse la sintesi perfetta di tutto il cinema che seguirà.
Persino un film di straordinaria potenza espressiva come Apocalypse Now, del 1979, può essere preso a esempio di questa tendenza. Del resto fu proprio Francis Coppola a pronunciare la frase: “I film degli anni ottanta supereranno i vostri sogni più arditi nel giro di pochi anni”. E nel film il personaggio di Lance dice: “Il Vietnam è come Disneyland”. Si sa che a scrivere la prima stesura della sceneggiatura fu, verso la metà degli anni settanta, John Milius, incoraggiato da Steven Spielberg e George Lucas, vale a dire due tra i maggiori fautori del cinema ludico anni ottanta. Proprio Lucas avrebbe dovuto dirigerlo inizialmente, e collaborò allo script mentre lavorava all’idea di Guerre stellari. Infine, su Apocalypse Now, Enrico Ghezzi ha scritto: “Un kolossal da discoteca, da radio, da televisione, che mostra la linea d’ombra su cui si muove tutto il cinema americano di successo: il quasi totale affidare alla forza (poco controllata) del sonoro, immagini sempre più lavorate e elaborate fotograficamente (luci, colori, valori plastici delle “cose” riprese)”.
Il Vietnam torna in altre pellicole in cui l’elemento spettacolare/avventuroso non è certo accessorio. Uno dei più conosciuti è Rambo (1982), di Ted Kotcheff. Raccontando di un reduce, John Rambo, che scatena una guerriglia personale contro lo sceriffo di una cittadina dello stato di Washington il quale lo ha accolto con ostilità, il regista sposta l’attenzione dal fronte all’America. Dopodiché innerva sul tema del difficile reinserimento nel tessuto sociale la retorica, indubbiamente coinvolgente, di un nuovo tipo di eroe, perfettamente addestrato al combattimento.
Nel documentario The American Nightmare (2000, Adam Simon), il maestro del make-up Tom Savini racconta l’esperienza in Vietnam, riflettendo sul fatto che le atrocità a cui ha assistito hanno fornito l’ispirazione per il suo lavoro cinematografico. “Il Vietnam mi ha trasmesso un’idea: se un trucco dev’essere orribile, deve essere come ciò che io ho visto”. Quindi non è forse casuale che anche il cinema del terrore utilizzi il Vietnam in più di un’occasione. Nell’episodio Time Out del film Ai confini della realtà (Twilight Zone, 1983), nel quale il regista John Landis cita Apocalypse Now, ma anche nel notevole Chi è sepolto in quella casa? (House, 1986), di Steve Miner. Uno scrittore di successo ossessionato dall’esperienza in Vietnam combatte con un suo ex-commilitone, morto in guerra e diventato uno zombi, che gli ha rapito il figlioletto. Il soggetto è firmato da Fred Dekker, una delle menti dell’horror anni ottanta.
Un reduce del Vietnam è il trucido capo di un gruppo di senzatetto del quartiere malfamato di Bowery Street, a Brooklyn. Come se non bastassero i problemi della vita di strada, a sterminarli ci pensa un liquore, il Viper, prodotto anni prima dal governo per usarlo come arma contro i vietcong. Uno dei più grandi operatori di steadicam, Jim Muro, realizza nel 1987 il suo unico film, Horror in Bowery Street (Street Trash), un horror cattivo e gore, che però conserva la leggerezza e l’attitudine ludica che caratterizzavano il genere in quel periodo. Con riferimenti a Buñuel, Kurosawa e Francis Bacon (ma anche alle comiche e ai fumetti).
Sempre a proposito del Vietnam, un discorso a parte merita Oliver Stone. Il film con cui si afferma in maniera definitiva è Platoon, del 1986, che nel 1987 vince quattro premi Oscar (tra cui miglior regia) e l’Orso d’oro al Festival di Berlino. Film per cui vale ciò che scrisse lo studioso J.-L. Bourget: “Si fa strada un nuovo classicismo, che si traduce nella vastità del disegno, nella bellezza della fotografia, nell’inquietudine dello spazio e del gesto, tutte qualità del cinema classico” (“Il cinema hollywoodiano. Da Griffith a Coppola”, ed. Dedalo, in G. Mancini, Michael Cimino, Le Mani).
Tra le pellicole più rappresentative del periodo ce n’è un’altra sulla guerra del Vietnam, Good morning, Vietnam (id., 1987), di Barry Levinson. Molto liberamente ispirato alla figura di un personaggio realmente esistito, il deejay Adrian Cronauer, di stanza a Saigon intorno al 1965, poco prima che il conflitto esplodesse in tutta la sua virulenza, è la summa di tutte le caratteristiche più evidenti di quell’epoca cinematografica, soltanto in apparenza meno sfavillante di altri titoli. Levinson ripropone la commedia militaresca/di guerra, sottogenere hollywoodiano già praticato negli anni quaranta-cinquanta. Utilizza stereotipi, un’atmosfera sognante e quasi fiabesca, aggiorna la figura chiave dell’eroe, usa la musica in maniera contrastante (evidente nella sequenza accompagnata dalle note di “What a Wonderful World”), non rinuncia al ribellismo e al giovanilismo, eccetera.
Come la guerra del Vietnam, il lavoro diviene il tema, più o meno centrale, di varie produzioni. Alberto Scandola ha scritto (Marco Ferreri, Il Castoro, pag. 28): “Alcune realtà rimosse con cinismo dalla cultura postmoderna: la solitudine, il dolore, la sessualità”. Se è vero che, come disse Jean-Luc Godard (nel 1980, non a caso), “c’è una componente enorme di sessualità nel lavoro”, si può forse comprendere perché anche il lavoro, pur presente nelle sceneggiature, finisca per essere solo un ingrediente tra i tanti, e mai davvero approfondito. Tra i film americani del periodo quello che sembra mosso dalle migliori intenzioni è Tuta blu (Blue Collar, 1978), diretto da Paul Schrader. Anche in questo caso però il discorso, soprattutto nella seconda parte, si concentra sulla corruzione del sindacato americano, e Tuta blu diventa una sorta di thriller paranoico nello stile tipico di Schrader (si vedano alcune sceneggiature precedenti, Taxi driver e Complesso di colpa, e le opere che seguiranno: Hardcore e American Gigolò).
Femminismo e quello che oggi verrebbe definito mobbing in versione commedia è Dalle 9 alle 5… orario continuato (Nine to Five, 1980), di Colin Higgins. Le tre impiegate protagoniste del film hanno un’idea molto hollywoodiana delle rivendicazioni, anche se immaginano le maniere più fantasiose di eliminare il capo.
La giovane Alex lavora come saldatrice a Pittsburgh ma sogna di essere ammessa all’Accademia di Danza. La coscienza operaia in Flashdance (1983), di Adrian Lyne, viene liquidata in due battute. Oltretutto Alex finisce per avere una storia d’amore con Nick, il suo datore di lavoro, che si rivela una brava persona e che la salva dalle grinfie del proprietario di un night club. La fabbrica è un luogo da cui fuggire (non a caso la protagonista è stata definita una Cenerentola moderna) e le immagini ricercate abbinate alla musica di Giorgio Moroder accompagnano il percorso di Alex.
Dello stesso anno è un altro film inglese, Local Hero, diretto dal regista scozzese Bill Forsyth. A ben guardare non è poi così diverso da Flashdance. Il dipendente di una multinazionale viene mandato in Scozia per trattare l’acquisto di un intero villaggio sul mare in modo da costruire lungo la costa una raffineria. Ma alla fine il presidente, recatosi di persona e conquistato dalla bellezza del luogo, cambia idea. Forsyth accentua il tono sognante, così il messaggio politico (l’aggressività delle multinazionali petrolifere) si stempera nella conciliazione, all’insegna dell’ecologismo. Il finale ha comunque un retrogusto malinconico, accentuato dal tema musicale “Going Home”, composto ed eseguito da Mark Knopfler.
La sfrenata fantasia visiva di Terry Gilliam fa di Brazil (id., 1985) uno dei capolavori del decennio. Ex-componente dei Monty Python, Gilliam inietta dosi massicce di umorismo corrosivo nella vicenda, grazie anche alla sceneggiatura scritta prima da Tom Stoppard e poi da Charles McKeown. Tra scenografie retro-futuristiche vertiginose e squarci onirici, digressioni grottesche e relazioni sentimentali inespresse, il protagonista, Sam Lowry, finisce sulla lista dei ricercati di un regime totalitario di cui costituiva un ingranaggio. C’è di tutto, in Brazil, compresa la canzone omonima, anche in questo caso usata in aperto contrasto con l’ambientazione cupa. Il discorso politico però si stempera nella splendida messinscena.
Oliver Stone, prima di affermarsi come regista, è stato un importante sceneggiatore. Tra i vari film che portano la sua firma, va ricordato Fuga di mezzanotte (Midnight Express), diretto nel 1978 da Alan Parker. Tratto dal libro basato sulla vera storia di Billy Hayes, vuole essere la denuncia del sistema carcerario. Turco, in questo caso. Infatti il giovane protagonista viene arrestato all’aeroporto di Istanbul con due chili di hashish addosso. Parker però forza la mano più sulla brutalità e il ghigno truce dei secondini, per cui gli spunti polemici e riflessivi annaspano, mentre emerge un certo sensazionalismo epidermico.
Tornando a Oliver Stone, Salvador (del 1986) testimonia ancora una volta che i suoi film, nonostante l’intenzione di fare cinema militante, sono in qualche modo legati alla tradizionale struttura hollywoodiana e alla riproposizione/rilettura che in questi anni ne fanno le nuove produzioni. Si vedano, a conferma, le rimostranze del regista nei confronti del protagonista James Woods per l’idea del rullino nascosto nel tacco della scarpa, definita dal regista troppo “hollywoodiana”.
Come abbiamo visto, le produzioni inglesi sono quelle che nel periodo preso in esame hanno messo in pratica con assiduità un cinema in cui l’impegno sfumasse ora nello spettacolare ora in uno struggente e a volte sin troppo suadente afflato poetico. Uno dei primi e dei più riusciti film di questo tipo è senza dubbio Momenti di gloria (Chariots of Fire), diretto nel 1981 da Hugh Hudson.
Il regista Roger Spottiswoode ha diretto nel 1983 uno dei film realizzati in questi anni incentrati sui regimi dittatoriali. Sotto tiro (Under Fire), ambientato nel Nicaragua del dittatore Somoza, è però anche una storia d’amore e un thriller carico di tensione. Di Spottiswoode è altrettanto, e forse ancor più significativo, il successivo Tempi migliori (The Best of Times, 1986). Ambientato in una cittadina californiana dove i protagonisti, Jack e Reno, decidono di rigiocare una partita di football americano persa malamente tredici anni prima. Particolarmente significativa è la scena nel quale i due amici vengono invitati dalle mogli a una cena pacificatrice che li aiuti a superare certi dissapori coniugali. La regola è che non si parli di football e sesso. I tentativi di affrontare argomenti seri (il Medio Oriente, il nucleare, eccetera), vengono però presto abbandonati per avviare una conversazione più intima, annaffiati da un buon numero di bicchieri di vino. Costruita come una scena da commedia americana classica, si conclude con un evidente e ulteriore affondo ludico, quando le donne scoprono che i mariti stavano assistendo, attraverso uno stratagemma, alla partita trasmessa in televisione.
Nel novero dei cineasti che hanno affrontato temi seri con un prevaricante senso dello spettacolo non poteva certo mancare il già citato Steven Spielberg, vero dominatore in quegli anni della produzione statunitense. Spielberg nel 1986 gira Il colore viola (The Color Purple), tratto dal romanzo di Alice Walker. Film sullo schiavismo e sulla condizione femminile, racconta di Celie, una povera ragazza della Georgia, vittima prima del patrigno e poi del marito violento. Spielberg, come scrisse Roberto Rombi, “conduce un’operazione brillante enucleando dal romanzo di Alice Walker (…) tutti i topoi del romanzo d’appendice”.
Uno dei film inglesi di maggior successo è Mission (The Mission, 1986), diretto da Roland Joffé. Ha piegato il contenuto ideologico (la critica al colonialismo) alle forme espressive e all’estetica del decennio, raggiungendo vertici emozionali nel connubio musica (composta da Ennio Morricone).
Altra produzione inglese è il musical Absolute Beginners (id., 1986), diretto da uno dei maggiori registi di video musicali di quelli anni, Julien Temple. Affronta temi come le tensioni razziali, i rigurgiti nazisti e la speculazione edilizia nella Londra del 1958. Ma anche lo sfruttamento della cultura dei teenager, esplosa alla fine degli anni cinquanta. Negli stessi anni in cui, guarda caso, negli Stati Uniti veniva coniato il termine “postmoderno”. Curiosamente, però, il film stesso cerca con un giovanilismo eccessivo e con uno stile accattivante di ottenere il consenso degli adolescenti.
Film dell’ultimo periodo estremamente rappresentativo di ciò che si intende per inconsistenza programmatica, Le streghe di Eastwick (The Witches of Eastwick, 1987), di George Miller, ha nel personaggio di Daryl Van Horne/Satana (interpretato da Jack Nicholson) un protagonista emblematico. Con discorsi filosofici circuisce tre donne al solo scopo di avere un figlio da loro. Si nasconde in sostanza dietro un’apparente ricchezza di significati, proprio come il film e come in generale il cinema di questo periodo.
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)











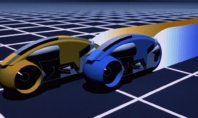


























 Total Users : 3083885
Total Users : 3083885