BRUNETTA, ARTISTA ECLETTICA DEL NOVECENTO
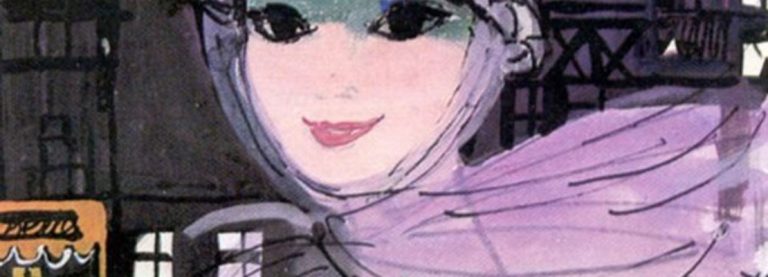
L’anno scorso, in un articolo dedicato alle illustrazioni di tre disegnatori che avevano profuso la loro arte nel creare singolaricarte da gioco(pubblicate poi daLa Matta, Almanacco dei giochi, 1940), avevo accennato a Brunetta, che per l’occasione aveva dato la sua interpretazione delle Regine. Bruna Moretti Mateldi © Farabolafoto, Milano foto Bruna Moretti, al secoloBrunetta(1904 – 1989), non è stata solo disegnatrice di moda originale, nel cui tratto innovativo e ironico confluiscono storia della moda, costume ma anche una descrizione arguta e gentilmente irriverente della società in cui viveva. È stata anche giornalista, pittrice, costumista, cartellonista. Ha disegnato per tutte le maggiori testate che si sono alternate da prima della Seconda guerra fino agli anni Settanta. La sua firma era ambita. Era ambita la sua presenza negli eventi mondani culturali, e in molti ha fatto parte di giurie. È stata richiesta oltreoceano più di una volta, in diversi tempi (lei aveva preferito restare in Italia, una prima volta per motivi familiari: il marito, il bravissimo disegnatoreFiliberto Mateldi, di cui era innamoratissima, non poteva più alzarsi dal letto). Ha attraversato indenne più periodi storici, sempre indaffaratissima, alle prese con schizzi perfino in quelle zone di tempo che dovrebbero essere una pausa. Che erano invece spunto continuo per un ritratto di gente, vita, vezzi, contraddizioni, singolarità, ironie eleganti. Lampi veloci trasfusi sulla carta in uno stile veloce e scarno, eclettico. Conosceva a fondo la storia dell’arte, la restituiva originale ai suoi contemporanei. Brunetta, copertina di “Scena Illustrata”, n. 5, maggio 1938 – Fonte: Biblioteca Nazionale Centrale, Roma. Courtesy of “Scena Illustrata” (da “L’ironia è di moda”, di P. Biribanti) Brunetta, copertina di “Grazia”, 22 giugno 1939 – Fonte: © Arnoldo Mondadori Editore (da “L’ironia è di moda”, di P. Biribanti) Brunetta, copertina di “Il Dramma”, 1 Aprile 1943 (ritratto dell’attrice Anna Proclemer) Quando si parla di moda in Italia oggi, e in Italia di moda si parla sempre, dobbiamo ringraziare anche lei, che fu pioniere e artefice nel passaggio avuto da prima della Seconda guerra al dopoguerra, dove si produsse l’inizio di quella che sarebbe stata la grande epoca italiana della moda, non ancora tramontata. L’avventura artistica di Brunetta nasce ancora prima degli anni Trenta, i futuristi hanno già sfondato la linea come avanguardia e si sono espansi in Europa, c’è fermento in ogni settore dove l’arte si può spingere. I dettami fascisti vogliono una donna florida e materna, dalle linee prosperose e rassicuranti, e spingono una moda e uno stile autarchici. Le donne filiformi e quasi scheletriche di Brunetta sono poco adatte a questo diktat e lei sarà ripresa più di una volta per questo motivo. Per contro, proprio questo veto che impedisce l’importazione o la copiatura di modelli esteri per favorire una produzione esclusivamente italiana, sarà la spinta verso quella supremazia nazionale nel campo della moda che ancora oggi il Paese detiene.È un periodo in cui nascono numerosi rotocalchi femminili che diffondono l’idea di moda anche nei ceti popolari. Brunetta già lavora da anni (in un primo periodo senza firmare), e collabora regolarmente aLa Domenica del Corrieree ad altre riviste aperte al tema della moda, spesso illustrando in coppia con il marito o dividendosi tra figurinismo, illustrazione di novelle, pittura e caricatura, pubblicità. In questi anni in cui si sta affermando presso il grande pubblico, è l’inizio della sua collaborazione alla rivista di teatroIl Dramma, diretta da Lucio Ridenti, collaborazione che andò avanti fino agli anni Cinquanta. Il quotidiano torinese,la Gazzetta del Popolo, primo fra tutte le testate che poi lo avrebbero imitato, aveva una sua pagina di moda a colori, e anche lì le illustrazioni furono commissionate a Brunetta.Commesse le provenivano da ogni dove:Il Balilla,La Donna,Dea,L’Illustrazione del Popolo, e poi, in seguito alla difficile malattia del marito, ancheLa Lettura, la storica rivista mensile illustrata delCorriere della Sera, il settimanale romano per l’infanziaNovellino.Negli anni Quaranta presta la sua collaborazione a numerose altre testate: la rivistaTessili Nuovi. Italviscosa, dove si alternarono artisti di altissimo spessore,Il Romanzo mensile, collana periodica di narrativa edita daIl Corriere della Sera,NovellaeI Romanzi di Novelladi Angelo Rizzoli,Scena illustrata, rivista mensile di arte letteratura e scienze,L’Illustrazione Italiana,Bertoldo, settimanale umoristico di Rizzoli,Le Grandi Firme, altra rivista di successo nata dagli sforzi di Pitigrilli (Dino Segre), il quindicinale illustratoLa Donna, il mensile illustratoAmica, la fortunataGraziadi Arnoldo Mondadori,Fili Moda, mensile di moda pratica della casa editrice Domus, il periodico femminileBellezza, con uffici a Londra, Parigi e Zurigo (siamo ormai nel primissimo dopoguerra), in grado di competere con le prestigiose rivisteVogueeHarper’s Bazaar. Brunetta, Eleganze femminili estive per le spiagge, in “La Domenica del Corriere”, 6 luglio 1924 – Fonte: Biblioteca di Storia moderna e contemporanea, Roma. Courtesy of Fondazione Corriere della Sera – Archivio Storico (da “L’ironia è di moda”, di P. Biribanti) Brunetta, illustrazione per la rubrica La moda e i bambini, in “Corriere dei Piccoli”, 24 novembre 1940 – Fonte: collezione dell’autrice. Courtesy of Fondazione Corriere della Sera – Archivio Storico (da “L’ironia è di moda”, di P. Biribanti) Brunetta: pubblicità per Italviscosa, 1940 Brunetta, 1932 Brunetta, modello Favro, in “Bellezza”, n. 1, novembre 1945 – Fonte: Biblioteca Nazionale Centrale, Roma (da “L’ironia è di moda”, di P. Biribanti) Brunetta, 1949 In realtà, fare la storia delle collaborazioni di Brunetta, significa raccontare, oltre alla storia della moda e a quella spicciola del Paese, anche quella dell’editoria e del giornalismo italiani del Novecento.Il dopoguerra rappresenta per l’Italia il momento in cui nasce l’occasione per andare oltreconfine e far conoscere la propria produzione di moda. Christian Dior stava sbancando con la sua collezione del 1947, laCorolle(ribattezzataNew Look). Nel febbraio del 1951 Giovanni Battista Giorgini apre per tre giorni Villa Torrigiani a Firenze, portando in sfilata la moda italiana e invitando i più importanti compratori statunitensi e l’aristocrazia nazionale. È un trionfo tale che a luglio si deve trasferire la rassegna al Grand Hotel, sul Lungarno Ognissanti, dove sono invitati esponenti dell’arte e della cultura, giornalisti di moda e affermati disegnatori. Non può mancare Brunetta.Il battesimo italiano era stato fatto, Firenze diventa capitale della moda italiana. A Roma l’alta sartoria romana conosce il suo grande momento, vestendo le dive d’oltreoceano venute a Cinecittà, sul set e fuori dal set. Milano veste la borghesia e l’aristocrazia, rispettando stili più sobri. Emilia Kuster Rosselli, reduce dalla sua collaborazione direttiva con Grazia, nel 1950 fondaNovità, una rivista che poi per modello, impostazione, grafica e target si sarebbe avvicinata così tanto aVogue, che il gruppo Conde Nast (editore diVogue America) l’avrebbe assimilata alle sue testate, per assumere il titolo definitivo diVogue Italia. Tra i collaboratori c’era Brunetta.Come è presente in qualità di delegata italiana al Primo incontro internazionale della moda tenuto a Venezia nel 1956, a Palazzo Grassi.L’innovativo quotidianoIl Giorno, nato nello stesso anno, ospita anche articoli di moda, tra cui troviamo collaborazioni di Brunetta.Apre anche delle sue personali di pittura. Realizza un manifesto pubblicitario per Martini & Rossi, settore in cui si era già cimentata negli anni Trenta e Quaranta lavorando per Davide Campari e altre case di pellicceria e cosmetici, tanto che nel 1956 l’Aiap, Associazione italiana artisti della pubblicità, le conferisce il premioGiarrettiera pubblicitaria. Persona carismatica, ironica e allo stesso tempo temuta per l’occhio vivace e verace che non conosce ipocrisia, diventa naturale il suo sodalizio con Camilla Cederna che sul settimanaleL’Espresso, fondato nel 1955, tiene la rubrica che avrebbe preso il titolo conosciuto dai più diIl lato debole, un misto innovativo di informazione e consigli dalla vena ironica e graffiante, illustrato dai lavori di Brunetta.Alle sue collaborazioni degli anni Sessanta, si aggiungonoAmica,La Donna,Annabella,La Modae l’edizione italiana diVogue.La casa di moda Albertina la vuole tra i suoi collaboratori come ideatrice di abiti. Brunetta, illustrazione per Il nuovissimo Galateo della contessa Clara illustrato da Brunetta, in “Annabella”, 24 novembre 1966 – Fonte: Biblioteca Nazionale Centrale, Roma. Courtesy of Fondazione Corriere della Sera – Archivio Storico (da “L’ironia è di moda”, di P. Biribanti) Brunetta, 1959 Brunetta, manifesto pubblicitario Calze SiSi, 1956 ca. – Fonte: Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso, su concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Polo museale del Veneto (da “L’ironia è di moda”, di P. Biribanti) Brunetta, 1959 Piovono i premi: nel 1968 ilSunday Mirror, l’edizione domenicale del quotidiano britannicoDaily Mirror, la annovera tra leEighteen World’s Most Powerful Womendell’anno. Le viene assegnato in ex aequo con altre ilMontenapoleone d’oro(all’interno del premioMontenapoleone Moda) dato ogni anno alle giornaliste che hanno saputo valorizzare la moda italiana. L’anno dopo, nel 1969, riceve ilPremio Illustrazione, promosso dal settimanaleEpoca. Il gallerista milanese Ettore Gian Ferrari la invita ad allestire una sua mostra nella propria prestigiosa galleria. E sempre nel 1968, Brunetta pubblicaMetamorfosi, una sorta di percorso evolutivo personale in cui le immagini sono le padrone di un viaggio dentro la moda. E non sono da meno gli anni Settanta, in cui le viene conferito ilPremio Irene Brine l’Oscar dell’Arte e della Moda. Continuano collaborazioni a testate prestigiose, tra cui la nuovaGT Giornata Tessilefondata dal giornalista Gianni Bertasso. Partecipa a giurie, a sfilate, la sua presenza è autoriale. Affianca Giulia Borgese sulle pagine delCorriere, illustrandone i testi. Pubblica nel 1981Il vizio del vestire, una sua raccolta di disegni, schizzi e bozzetti creati in oltre cinquant’anni di attività, a cui seguiranno altre pubblicazioni, anche con testi redazionali di suo pugno. È sempre impegnata tra gallerie e collaborazioni.Dona al Centro studi e archivio della comunicazione (Csac) dell’Università di Parma una importante collezione di suoi disegni, schizzi e bozzetti, tuttora conservati in questa sede. Brunetta, Mode Story, in “Corriere dei Ragazzi”, 2 gennaio 1972 – Fonte: Biblioteca Nazionale Centrale, Roma. Courtesy of Fondazione Corriere della Sera – Archivio Storico (da “L’ironia è di moda”, di P. Biribanti) Brunetta: abito da sera, 1972 Dal taccuino di Brunetta, in “Amica”, a. i, n. 4, 15 aprile 1962 – Fonte: Biblioteca Nazionale Centrale, Roma. Courtesy of Fondazione Corriere della Sera – Archivio Storico (da “L’ironia è di moda”, di P. Biribanti) Brunetta, 1975 Brunetta, 1975 Brunetta: 1968-69 Brunetta, anni Settanta Brunetta, 1966 Brunetta, anni Sessanta Brunetta: “Il vizio del vestire” (Milano, Edizioni delle Donne, 1981) Ho scoperto che proprio nel marzo di quest’annoPaola Biribantiha pubblicato un bel saggio su questa nostra disegnatrice, intitolatoL’ironia è di moda – Brunetta Mateldi Moretti, artista eclettica dell’eleganza,Con prefazione di Maria Vittoria Alfonsi(Carocci, 2018).Un saggio ben scritto e interessante anche per l’aspetto storico e non solo culturale e di costume, dove il lavoro indefesso e paziente della saggista si indovina per la stupefacente e ricchissima ricerca bibliografica, le interviste “in diretta” ottenute da chi Brunetta l’ha conosciuta, l’umanità con cui ha saputo raccontare una personalità-pilastro della cultura italiana.Ne è uscito un ritratto di Brunetta fresco è vivo, capace di interessare anche chi del Novecento ha un’immagine morta. Un ritratto accuratissimo, documentato, corredato di moltissime immagini, e anche un po’ da brividi, se si pensa che ogni volta in cui un grande se ne va, resta un’eredità altrettanto grande da raccogliere che prima si deve far propria, se poi la si vuol superare per raccontare qualcosa di nuovo. Un’eredità difficile da mettere a frutto, oggi, un po’ perché lo spessore culturale generale si è andato assottigliando e il gusto per la qualità è in discesa, un po’ perché non si permette ai veri talenti di emergere schiacciati sotto il peso di relazioni parentali e amicali che spingono l’improbabile in virtù di una connessione personale, un po’ perché son tempi in cui troppo spesso si grida al miracolo perché non si sa più che quel miracolo c’era già stato e se ne sta guardando solo una copia, il più delle volte fatta male e senza la consapevolezza che sia una copia. Son tempi di realizzo veloce, i nostri. Contano più la campagna pubblicitaria e un incasso immediato che non il valore delle cose. L’importante è vendere e vendersi, non importa se anche sia solo aria.Per forza poi le cose che dovrebbero essere belle, il cinema, la letteratura, l’arte, il fumetto, la musica, durano una stagione o due nei casi più fortunati, poche repliche, uno striminzito numero di albi, montagne di copie invendute. Spesso sono all’oscuro di un prima, pretendono di reinventare il presente, annoiano subito.In Brunetta lospessoree il senso diqualitàerano profondi. Chi fosse e come abbia potuto dare così tanto in modo eclettico e aggiornato via via che i tempi cambiavano, mantenendosi al contempo sempre a un livello qualitativo altissimo, lo leggiamo nel saggio di Paola Biribanti, scorrevole, approfondito, accattivante. Si può leggere quasi come un romanzo, se ne esce più sapienti e con l’impressione di avere vissuto ogni epoca in prima persona, grazie alla sua penna leggera e accurata che riporta in luce una personalità chiave del nostro Novecento culturale, oggi mi pare un po’ dimenticata. Eppure, non si può parlare di moda né di storia dell’illustrazione italiane senza citarla.
